Le fonti a cui viene attribuita la paternità del termine telemedicina sono molteplici e vanno dalla pubblicazione, sul magazine statunitense Radio News dell'articolo intitolato 'The radio doctor - maybe'(1927), al primo riferimento nella letteratura medica (trasmissione di RX da West Chester a Philadelphia (1950)),all'insieme dei progetti mirati al monitoraggio delle condizioni fisiche degli astronauti nel corso delle prime missioni spaziali (inizi anni '60). Fatto sta che sono circa una quarantina d'anni che si assiste ad un proliferare di progetti miranti a verificare le potenzialità dell'Information e Comunication Technology applicate alla pratica medica. Per dare una idea della dimensione del fenomeno, si può dire che nel 1997 negli Stati Uniti sono stati effettuati circa 250 mila studi diagnostici teleradiologici. Durante lo stesso anno sono stati eseguiti 46.231 teleconsulti tramite video-comunicazione interattiva e/o immagini 'store-and-forward'. Le specializzazioni più richieste sono risultate essere in particolare la psichiatria (17,9%), la cardiologia (16,7%), l'oculistica (9,6%) e l'ortopedia (5,7%).
Uno dei siti di maggior interesse per coloro che si occupano di questa disciplina (tie.telemed.org) annoverava nel proprio database circa 7000 articoli a gennaio 2000, circa 9000 a gennaio 2001 mentre a novembre 2003 gli articoli segnalati erano 14.077.
Ad un aumento così consistente degli articoli si contrappone, tuttavia, un diminuzione in questi ultimissimi anni del numero di progetti attivi nel campo della telemedicina che può risuonare come primo campanello d'allarme circa la effettiva messa in produzione di tali progetti. Infatti lo stesso sito censiva 200 progetti a gennaio 2000, 254 a gennaio 2001 mentre nel novembre 2003 i progetti censiti erano 126.
Occorre quindi interrogarsi su quali siano le motivazioni che, a fronte di un movimento che appare compatto nel proporre la telemedicina come strumento indispensabile per la medicina del terzo millennio, fanno si che nessun paziente afferente al Sistema Sanitario Nazionale abbia mai avuto la percezione di essere stato curato con il supporto di tali metodologie.
Innanzitutto va sottolineato come non sia solamente la Sanità ad essere investita dal fenomeno dell'ICT, ma tutte le attività del vivere quotidiano. Il piano d'azione 'Europe 2005', presentato ed approvato dal Consiglio Europeo di Siviglia del 2002, fissa l'obiettivo generale, per l'Europa, di dotarsi entro il 2005 di moderni servizi pubblici on line, come traino alla domanda e all'alfabetizzazione informatica della popolazione. Tale obiettivo è conseguibile attraverso azioni nel settore della Pubblica Amministrazione (e-government), in quello della formazione (e-learning), nel settore del commercio (e-business) ed in quello sanitario (e-heath). In Italia questo si è tradotto nell'attivazione di un Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione composto dai principali Ministri coinvolti nello sviluppo dell'ICT (Attività Produttive, Beni Culturali, Comunicazioni, Economia, Funzione Pubblica, Interno, Istruzione, Politiche Comunitarie, Salute, Welfare, oltre che dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) che ha portato, all'inizio del 2003 all'emanazione di nuove politiche per l'innovazione tecnologica che prevedono 5 aree di intervento: 'il cittadino', 'l'innovazione del Paese', 'le competitività del sistema delle Imprese', 'la digitalizzazione della P.A. (e-government)', 'l'azione internazionale'. [1]
La Sanità rappresenta, in tal senso, uno dei settori prioritari, in particolare nell'ambito dell'area di intervento 'innovazione del Paese' e, all'interno di questa, nella sotto area 'grandi sistemi pubblici in rete'.
A tal proposito un recente studio apparso sul Sole24ore Sanità evidenzia come il 77% delle A.S.L, l'84% delle Aziende Ospedaliere e l'86% degli I.R.C.C.S. dispongono di siti Internet e quindi siano potenzialmente presenti in rete. A fare da contraltare a questo dato apparentemente incoraggiante, vi è tuttavia la tipologia dell'offerta informativa che tali siti propongono. Nel 54% dei casi si tratta di quelle che lo studio definisce e-information attive, per il 27% delle ancor più povere e-information passive e solo per il 18% vengono forniti e-services. Infine va rimarcato che la quasi totalità dei servizi offerti in rete orbita intorno al tema della 'prenotazione on-line'.
Lo stesso Osservatorio della Telesanità 2003, della Regione Lombardia, definisce i siti sanitari 'vetrina di tipo informativo con pochi esempi di servizi transattivi a disposizione degli utenti'. [1] L'approccio del Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica (CBIM) ai servizi di telemedicina, proviene da un percorso abbastanza originale a seguito di un'esperienza decennale nel campo della consulenza direzionale nella realizzazione dei Sistemi Informativi Ospedalieri.
Il processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie, (avviato con D.L. 502/92) in termini di miglioramento della produttività dei servizi offerti dalle Aziende Ospedaliere, ha, infatti, imposto strategie innovative circa le scelte dei processi di informatizzazione sia nella fase progettuale/attuativa che in quella successiva di governo e di gestione del sistema.
La necessità di valutare i costi di produzione delle prestazioni sanitarie in tempi relativamente rapidi, ha reso indispensabile la disponibilità di strumenti informatici adeguati a rilevare l'insieme delle prestazioni effettuate ed i costi sostenuti per erogare tali prestazioni. L'esperienza maturata in tale settore ha permesso al CBIM di conoscere dettagliatamente i flussi informativi inerenti l'erogazione di prestazione sanitarie e di individuare quelle funzionalità, all'interno di tali flussi, erogabili per via telematica.
A livello generale l'erogazione di prestazioni sanitarie coinvolge i seguenti soggetti e seguono il processo sotto descritto.
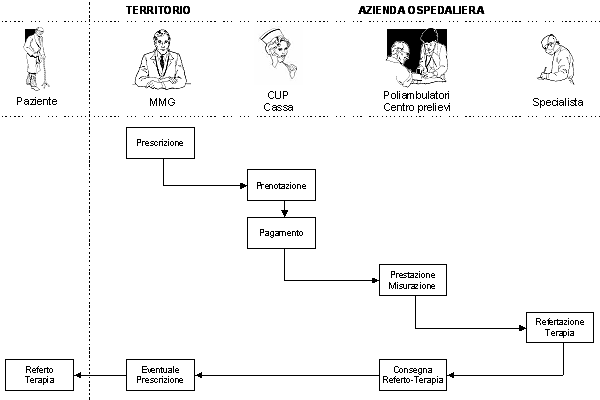
Fig. 1: Flusso tradizionale nell'erogazione di prestazioni sanitarie
Lo schema (figura 1) evidenzia che, attualmente, la maggior parte del processo è erogato presso le strutture dell'Ente Sanitario costringendo il cittadino ad effettuare continui spostamenti. A livello territoriale rimane esclusivamente l'attività di prescrizione specifica dei Medici di Medicina Generale.
Scopo dell'introduzione dei servizi di telemedicina consiste nell'esternalizzare, totalmente o in parte, alcune fasi del processo di erogazione di servizi sanitari, che attualmente sono eseguite all'interno delle strutture delle Aziende Ospedaliere, presso i Poli Sanitari Territoriali geograficamente distribuiti.
La figura seguente (figura 2) evidenzia come l'introduzione di servizi di telemedicina consente di semplificare il percorso di accesso alle prestazioni sanitarie da parte del cittadino mediante una differente distribuzione dei compiti tra Territorio ed Ente Sanitario.
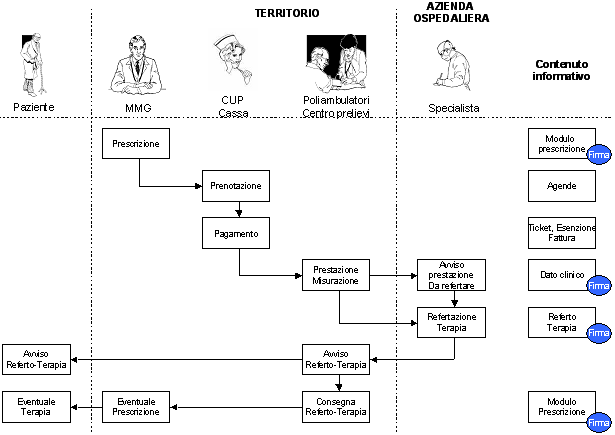
Fig. 2: Flusso di erogazione di prestazioni sanitarie mediante strumenti telematici.
In questo caso, la maggior parte del processo avviene a livello territoriale lasciando all'Ente Sanitario i compiti necessari a mantenere la stessa qualità del livello di assistenza.
La rilevazione remota del parametro sotto esame (Prestazione Misurazione) può avvenire tramite i dispositivi più opportuni, ormai disponibili, sul mercato dell'ICT, a costi decisamente contenuti: si va dallo stetoscopio elettronico alla trasmissione elettronica dell'ossimetria del polso e dei parametri della funzionalità respiratoria; dal controllo del livello di glucosio nel sangue e dell'immagine visiva della siringa di insulina prima dell'iniezione alla misurazione a distanza della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca del feto. Di fatto tale elenco copre gran parte dei dispositivi tradizionalmente disponibili all'interno dell'Ente Sanitario.
La condizione ideale si verifica nel momento in cui il Polo Sanitario Territoriale (studio associato di MMG, Poliambulatorio, farmacia, …) è in grado di svolgere attività di CUP, cassa, Centro Prelievo/Misura. Ciò permette di offrire le fasi "esternalizzabili" del processo in uno stesso luogo ed in taluni casi in stretta sequenza temporale.
La continuità del processo, attualmente garantita dalla presenza del paziente che porta con sé informazioni e documentazione, può, in questo modo, essere realizzata mediante sistemi telematici ed informatici. L'adozione della firma digitale e l'utilizzo di strumenti di trasmissione telematica sicuri (crittografia) garantiscono la validazione dei dati.
La metodologia derivante da tali principi ha portato all'implementazione, da parte di CBIM, di diversi progetti telematici che hanno avuto come committenza la Comunità Europea, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Innovazione Tecnologica.
Particolarmente significativo a tal proposito appare il progetto ITACA 2002, finalizzato alla costituzione di un network di 17 Centri Cefalea della regione Lombardia promosso e coordinato dall'IRCCS Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia.
Il progetto, attivato nel 2002, ha consentito di sviluppare strumenti telematici di lavoro cooperativo per l'erogazione di servizi sanitari (Scheda Paziente, Diario paziente, Second Opinion,...) tra specialisti ed operatori sanitari inerentemente a problematiche riguardanti pazienti affetti da patologia cefalalgica.
I servizi implementati sono accessibili attraverso un Portale Sanitario appositamente predisposto (www.retedeccellenzacefalee.it).
Le esperienze compiute documentano che, allo stato attuale, gli ostacoli che si frappongono al trasferimento delle soluzioni sperimentalmente validate nei processi produttivi sanitari non sono connessi all'affidabilità delle tecnologie impiegate, e neppure alla praticabilità di tali soluzioni nel contesto attuale e concreto dell'organizzazione sanitaria, ma derivano soprattutto da due nodi ancora irrisolti: la non definizione di un criterio di remunerazione (tariffa o DRG) per le prestazioni rese per via telematica e le incertezze indotte da un quadro normativo che, in materia di sicurezza e privacy, è tuttora complesso ed in continua evoluzione.
Inerentemente al processo di remunerazione, va sottolineato come tale processo sia stato attivato anche negli Stati Uniti in tempi recentissimi. A partire da gennaio 1999, infatti, l'ente per l'amministrazione finanziaria della Sanità statunitense - Hcfa (health care financial administration) - ha stabilito di rimborsare, pur con notevoli restrizioni, l'attività dei medici che erogano servizi di teleassistenza ai pazienti del 'Medicare'. Il rimborso di Medicare va comunque interpretato positivamente come presa di coscienza, da parte delle istituzioni, della crescente importanza assunta dalla telemedicina. [2]
Se è intuitivo, quindi, il rilievo che assume la remunerazione delle prestazioni in un sistema orientato all'equilibrio di bilancio e fondato sul pagamento "a caso trattato", le questioni inerenti alla sicurezza ed alla privacy meritano specifica attenzione in quanto criticità intrinseche al dominio sanitario, che è caratterizzato per un verso dal trattamento, necessariamente riservato, di dati sensibili, e d'altro canto da esigenze inderogabili di certificazione, autenticazione, integrità, non ripudiabilità, firma e certificazione temporale della documentazione diagnostica e clinica. [3].
Infine, c'è chi sostiene, e noi siamo tra quelli, che si potrà parlare di telemedicina quando il termine telemedicina sarà definitivamente scomparso dall'uso comune e l'Information and Comunication Technology verrà considerata uno dei tanti mezzi utilizzati nell'ambito della complessa struttura dei Servizi sanitari.
Bibliografia
[1] G. Borghi, M. Mena. Osservatorio Telesanità 2003. Quaderno AIM n. 45 Milano, 2003.
[2] S.W. Strode, S. Guske, A. Allen. Verso 'normali' cure virtuali. Management de Il sole24ore Aprile 2003.
[3] P. Cristiani, F. Germagnoli. Telemedicina: dai progetti ai servizi. Implicazioni nell'organizzazione sanitaria
F. Germagnoli, M. Pagani
(Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica - Pavia)



